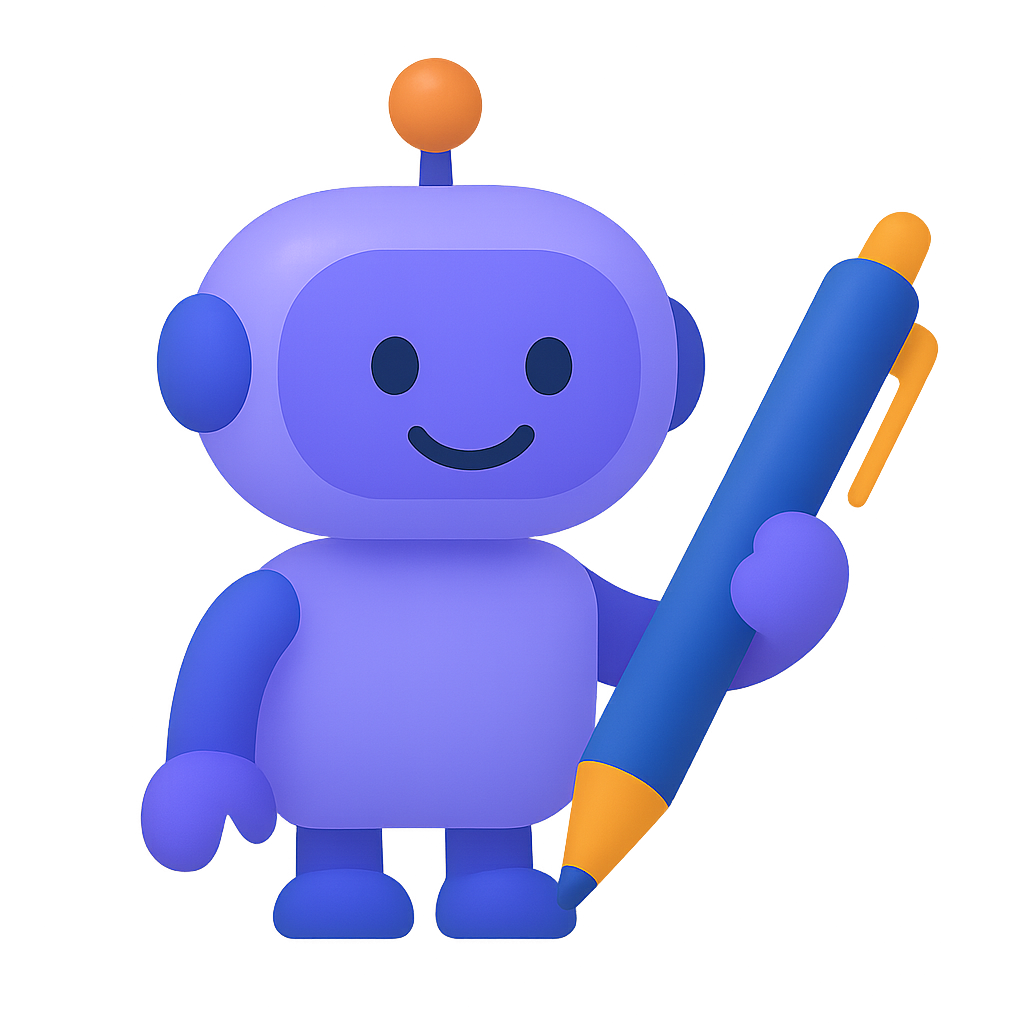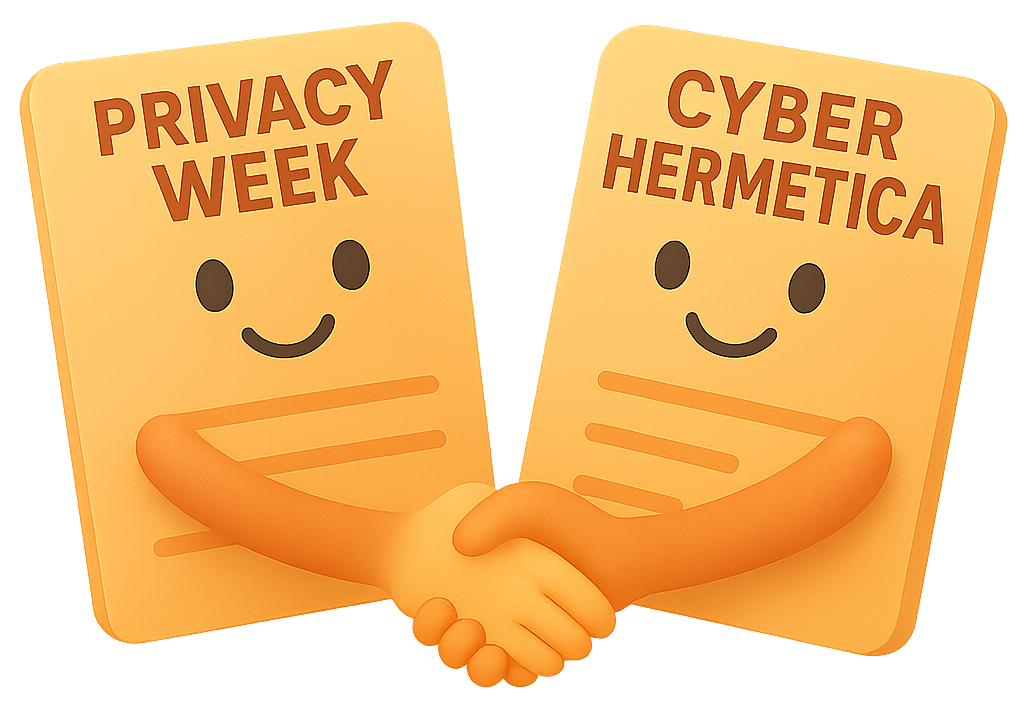Il capitale umano europeo
Oggi parliamo di: Capitale umano e brain drain in Europa / L'UE ancora dubbiosa sulla normativa IA / Monete umane o algoritmiche.
L'EDITORIALE PW
Riflessioni su cybersecurity, privacy e sull’impatto sociale della tecnologia.
di Matteo Navacci, data protection & cybersecurity advisor, co-fondatore di Privacy Week
Il capitale umano europeo
Un recentissimo documento del Parlamento Europeo analizza il ruolo delle competenze in intelligenza artificiale nel plasmare la futura forza lavoro europea, alla luce della crescente automazione, delle sfide educative e delle disuguaglianze regionali.
L’intenzione del Parlamento e certamente anche della Commissione Europea è di garantire una transizione digitale sufficientemente competitiva, promuovendo l’alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale, la formazione continua e la coesione sociale a fronte di possibili impatti sistemici derivanti dall’uso sempre più diffuso di queste tecnologie.
In effetti, nonostante l’assenza di un’industria della “Big Tech”, pare che anche la vecchia Europa sarà profondamente segnata dall’intelligenza artificiale. Secondo il Parlamento Europeo entro pochi anni addirittura il 90% dei lavori richiederà competenze digitali, rendendo l’alfabetizzazione tecnologica un prerequisito basilare per l’occupabilità in generale.
Da un lato, sono sempre più richieste capacità come programmazione, machine learning, analisi dati e cybersecurity. Dall’altro, emerge anche la necessità di possedere qualità meno tangibili ma altrettanto cruciali: creatività, empatia, pensiero critico, collaborazione, capacità di risolvere problemi complessi e, aggiungo io, capacità di linguaggio. Queste abilità non sono sostituibili dalle macchine, ma diventano invece complementari, soprattutto nei ruoli in cui l’essere umano lavora a stretto contatto con sistemi ICT complessi.
Secondo il Parlamento sarà questa la vera “fusione” tra umano e IA, forgiando anche ruoli del tutto inediti come l’AI Ethicist o il Digital Twin Engineer…
E purtroppo, proprio lo stato pietoso dell’industria tecnologica in Europa ci mette in difficoltà: tutti vogliono persone competenti e abili nell’usare la tecnologia, ma c’è una dura lotta a livello internazionale per attrarre capitale umano. E noi non siamo affatto in pole position.
Qui si inseriscono anche iniziative come la “Union of Skills” promossa dalla Commissione Europea il 5 marzo 2025 — una strategia per rafforzare il capitale umano dell’UE, affrontando carenze di competenze e disallineamenti tra domanda e offerta di lavoro. Non mi è chiaro in che modo iniziative del genere possano aiutare, considerando che il capitale umano viene attratto dalla forza gravitazionale del capitale finanziario e tecnologico e non viceversa — due aspetti su cui l’Unione Europea non brilla.
Per non perdere competitività (che forse non è mai esistita), dobbiamo affrontare la sfida del “brain drain” sia interno che esterno. Politiche europee come la Blue Card o Choose Europe non basteranno: serve coltivare metodi concreti per trattenere i talenti e valorizzare sia la dimensione umana che il capitale tecnologico.
ORIZZONTI DI GOVERNANCE AI
Novità e delucidazioni sulle politiche globali per l’IA.
di Luca Nannini, Senior AI Policy & Standards Specialist
Periodo: 10 - 17 giugno 2025
Unione Europea
Il dibattito sul posticipo dell'AI Act non è più un tabù ai piani alti della Commissione Europea. La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha dichiarato apertamente che se standard e norme non sono pronti per agosto 2026, occorre posticipare le scadenze.
Il viceministro polacco agli Affari digitali Dariusz Standerski ha messo l'opzione pausa sul tavolo durante la presidenza polacca del Consiglio UE. A questo riguardo, il Presidente di UNINFO Domenico Squillace ha giustamente spiegato che ci troviamo in un "contesto senza precedenti" nella normazione tecnica, dovendo definire per la prima volta standard che coinvolgono concetti immateriali come i diritti fondamentali. Ha sottolineato che "meglio arrivare con qualche mese di ritardo, ma con standard robusti, condivisi e applicabili".
Il Parlamento Europeo non si opporrà al ritiro da parte della Commissione di due importanti proposte: la Direttiva sulla Responsabilità dell'IA (AILD) e il Regolamento sui Brevetti Essenziali Standard (SEP). Il Partito Popolare Europeo ha invertito una precedente raccomandazione di opposizione al ritiro.
La Commissione Europea chiarirà nelle prossime linee guida sul regime ad alto rischio dell'AI Act se i produttori di prodotti con funzionalità IA integrate devono conformarsi al regime ad alto rischio anche quando utilizzano standard armonizzati invece di valutazioni di conformità di terze parti sotto le leggi di sicurezza settoriali UE.
L'europarlamentare Axel Voss ha citato dati dell'Economist che mostrano come "l'UE non sia nella corsa - non nell'IA, non nelle biotecnologie, e non nei semiconduttori", mentre Washington e Pechino raddoppiano gli investimenti con strategie coordinate e visioni audaci.
Stati Uniti
New York è diventato il primo stato americano a richiedere ai datori di lavoro di dichiarare, negli avvisi WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), se l'intelligenza artificiale ha contribuito ai licenziamenti di massa. L'aggiornamento, effettivo da marzo 2025, aggiunge una casella di controllo al modulo del datore di lavoro specificamente per i licenziamenti legati all'IA, stabilendo un precedente significativo per la trasparenza sulla forza lavoro riguardo all'impatto dell'IA sull'occupazione.
Ricerca e sviluppo
Un nuovo studio del MIT (pre-review) intitolato "Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay-Writing" fornisce evidenze neurologiche chiare che l'uso di ChatGPT modifica il modo in cui focalizziamo, creiamo e critichiamo.
Lo studio ha tracciato il flusso di informazioni tra 32 regioni cerebrali di 54 studenti mentre scrivevano saggi in stile SAT, confrontando tre strumenti: nessun aiuto, Google e GPT-4o. I risultati mostrano che l'uso puro di GPT ha prodotto la connettività fronto-parietale e temporale più debole, segnalando un controllo esecutivo più leggero e un'elaborazione semantica più superficiale.
Apple AI Research ha pubblicato uno studio intitolato "The Illusion of Thinking" che smantella le affermazioni sui modelli di ragionamento grandi (LRM). Utilizzando quattro puzzle controllati (Torre di Hanoi, Attraversamento del Fiume, Salto della Dama e Mondo dei Blocchi), i ricercatori hanno dimostrato che quando la complessità supera il territorio che richiede capacità cognitive a livello umano, il tasso di successo scende a zero. Lo studio rivela che questi sistemi non possono astrarre, generalizzare, applicare regole logiche o verificare i risultati.
FINTECH PLAZA
Ogni due settimane, opinioni e approfondimenti sul mondo del Fintech.
di Angelica Finatti, Blockchain Expert (bancario-assicurativo), TEDx Speaker
Moneta umana o algoritmica?
“Se l’economia è una scienza, deve avere una banca centrale che ne coordini le leggi.”
— Mario Draghi
Mario Draghi non ha mai pronunciato queste esatte parole, ma questa frase simboleggia il suo pensiero nei confronti dell’economia europea. Quindi la domanda è: se la BCE non esistesse ci troveremmo nel sogno di massimalisti digitali oppure in un incubo orwelliano?
Se la Banca Centrale Europea non esistesse, se, anziché affidarsi a un’istituzione sovranazionale per custodire la stabilità monetaria del continente, l’Europa avesse scelto un’altra via: una moneta unica digitale, nata non dalla concertazione tra Stati ma dall’algoritmo? Sarebbe questa la nuova utopia tecnocratica… o un passo verso un futuro dominato da un controllo disumanizzato, come temeva Orwell?
Dal 1999, con l’introduzione dell’euro e la nascita della BCE, l’Europa ha intrapreso un cammino di integrazione economica senza precedenti, basato su regole rigorose, sacrifici sovrani e, soprattutto, la promessa di una stabilità condivisa. Ma cosa sarebbe accaduto se questo centro non fosse mai stato istituito?
Vedete, senza la BCE, ogni Stato avrebbe mantenuto la propria moneta nazionale, con politiche monetarie autonome e tassi d’interesse divergenti. Non è una sorpresa che gli stati per essere parte dell’Europa cedano la propria sovranità su alcune materie.
Il mercato interno, dunque, sarebbe rimasto frammentato, le speculazioni valutarie avrebbero prosperato e le crisi — come quella del 2008 o del debito sovrano del 2011 — avrebbero inferto ferite ben più profonde. E sento anche io ora le voci dei massimalisti di Bitcoin che gridano: “Bitcoin non ha bisogno di essere salvato nelle crisi: è la crisi che, semmai, conferma la necessità di Bitcoin”. Affascinante idea, che purtroppo, ad oggi resta ancora distante dalle complesse realtà di una governance macroeconomica globale, dove la rigidità matematica può essere tanto una virtù quanto un rischio paralizzante.
In uno scenario simile, l’assenza di un’autorità centrale capace di intervenire con prontezza (come fece Draghi con il celebre “Whatever it takes”) avrebbe probabilmente portato alla rottura dell’Unione Monetaria stessa, se mai fosse nata.
Però permettetemi di spingermi oltre e aggiungiamo una variante futuristica a questo scenario. Supponiamo che, in assenza della BCE, l’Europa abbia comunque adottato una moneta unica, ma non statale: una valuta digitale, programmabile, decentralizzata, magari ispirata a tecnologie blockchain. Un euro postmoderno, senza padroni e senza banchieri centrali.
La promessa è affascinante: trasparenza assoluta, costi di transazione minimi, resistenza alla manipolazione politica, indipendenza dei circuiti di pagamento. Ogni cittadino potrebbe gestire il proprio denaro su un registro pubblico immutabile (aka Blockchain), senza banche centrali né ministeri del Tesoro. Allora qui sento l’eco di Thomas Moore e più avanti nel tempo, proprio di Orwell.
In 1984, Orwell immaginava un mondo governato da meccanismi impersonali, dove ogni respiro era controllato da un potere invisibile. Ora, sostituiamo The Big Brother con una blockchain globale: se ogni transazione è tracciabile, se ogni pagamento è programmabile, dove finisce la nostra libertà economica? Un sistema monetario senza organi politici potrebbe trasformarsi in una macchina spietata, incapace di discernere tra rigore e giustizia?
La BCE, per quanto criticabile per alcuni, ha un volto, una responsabilità, una dialettica democratica. Un algoritmo no. Esso esegue. E nel suo gelo calcolato può ignorare la sofferenza umana, le crisi sociali, la necessità di compassione economica, la voglia di rivalsa.
Permettetemi di citare la città della mia università. Quando l’Unione Europea firmò il Trattato di Maastricht nel 1992, pose le basi per la nascita dell’euro e della BCE, scegliendo la via della stabilità attraverso la rinuncia parziale alla sovranità monetaria. La politica fiscale sarebbe restata nazionale, ma quella monetaria sarebbe stata europea, vincolata all’obiettivo della stabilità dei prezzi.
Questa scelta ha generato tensioni — come dimostrano i vincoli del Patto di Stabilità e Crescita — ma ha anche offerto protezione. Senza BCE, ogni Stato sarebbe stato solo davanti ai mercati. Con una moneta digitale, sarebbe solo davanti all’algoritmo, creato comunque da esseri umani. Disturbo sempre Orwell e mi chiedo se non possa quindi crearsi un’altra Animal Farm, alla fine, gli animali erano diventati più umani degli umani stessi.
Una moneta digitale senza una banca centrale può sembrare moderna, ma rischia di essere cieca. Una banca centrale senza legittimità popolare rischia di essere sorda. La sfida del XXI secolo non è sostituire le istituzioni con il codice, ma renderle più intelligenti, trasparenti, giuste. Metterle a contatto con le necessità del mercato, che non è fatto solo da movimenti di borsa o da compra-vendita di asset digitali. Insomma: unire il governo con lo strumento.
Perché, come ci ricorda Orwell, il pericolo non è solo essere sorvegliati. È essere governati da qualcosa che non ci guarda affatto. Basta rivoluzionare un sistema economico, se la rivoluzione di per sé non ha governo?
NEWS BREVI
ChatGPT vs cybercrime. Un rapporto di OpenAI mostra il modo in cui strumenti come ChatGPT possono aiutare a bloccare campagne dannose di ingegneria sociale e smantellare reti cybercriminali. Qui un articolo sul tema.
I contenuti formativi dell’ENISA per la NIS2. L’Agenzia Europea per la Cybersicurezza ha pubblicato una serie di materiale informativi che coprono tutti gli aspetti della Direttiva NIS2 — dalla gestione del rischio alla notifica degli incidenti. Qui per scaricare il materiale.
Cavilli per privacysti. Il trattamento di dati particolari (es. salute) è lecito in presenza di una base giuridica tra quelle indicate dall’articolo 9 del GDPR, o è sempre necessario avere anche una base giuridica tra quelle generali dell’articolo 6? Secondo la sentenza C-667/21 del 21 dicembre 2023 della CGUE servono sempre entrambe. L’articolo 9 sarebbe quindi un elemento ulteriore, e non alternativo, all’articolo 6.
PRIVACY WEEK 2025 - MILANO & AUTODROMO DI MONZA
📍 Ottobre, Milano – Un appuntamento da non perdere per chi vuole capire davvero dove ci sta portando la tecnologia.
🎯 Da cinque anni Privacy Week è un’esperienza viva, ibrida, fuori dagli schemi: al centro ci sono le persone e le grandi domande del nostro tempo. Parliamo di privacy, cybersecurity, intelligenza artificiale, ma lo facciamo con uno sguardo trasversale: geopolitica, economia, lavoro, salute, arte, relazioni, identità.
A ottobre, oltre ai soliti appuntamenti milanesi, saremo anche all’Autodromo Nazionale di Monza, per una giornata dedicata interamente alla tecnologia, alla cybersecurity e ai rombi di motore.
I nostri Sponsor potranno accedere alla giornata esclusiva presso l’Autodromo e incontrare centinaia di CEO, innovation manager, HR directors, marketing directors, professionisti della cybersecurity e investitori. Da non perdere le esperienze adrenaliniche, come la guida in pista o la simulazione di un pit stop Formula 3!
💡 Vuoi capire come diventare sponsor e far parte di Privacy Week 2025? 👉 Contattaci ora. Le migliori storie iniziano con una conversazione.
ALTRE DIMENSIONI DELLA TECNOLOGIA
Cyber Hermetica è la newsletter che ti accompagna nelle profondità dell’Era Digitale, tra riflessioni esistenziali e pratiche per orientarsi in un mondo che sta cambiando velocemente. È un riferimento unico per esplorare la convergenza tra umanità e tecnologia, sovranità digitale e cibernetica.
Per i lettori di Privacy Week uno sconto esclusivo del 25% sull’abbonamento annuale a Cyber Hermetica. 👉 Approfittane ora e inizia il tuo percorso, clicca qui!
I nostri social
Segui anche i nostri social network e unisciti a un pubblico di più di 25.000 utenti!